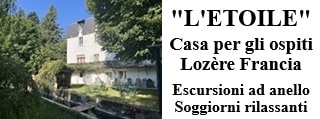La cattedrale di Notre-Dame di Puy |

 Le disposizioni
strane che presenta, caratteristiche di essa e visibilmente dettate dall'esiguità di sostituzione, la lasciano senza parentela diretta con nessun'altra. Non si sa nulla di positivo sulla
data della sua costruzione, ma l'esame del monumento stesso permette di affermare che è stato costruito nella seconda metà del XII secolo, iniziando dall'abside e, poiché il suolo mancava, si ebbe
l'audace idea di lanciare le navate occidentali sopra un basamento voltato, il "grande portico", raddoppiando così l'altezza della facciata.
Le disposizioni
strane che presenta, caratteristiche di essa e visibilmente dettate dall'esiguità di sostituzione, la lasciano senza parentela diretta con nessun'altra. Non si sa nulla di positivo sulla
data della sua costruzione, ma l'esame del monumento stesso permette di affermare che è stato costruito nella seconda metà del XII secolo, iniziando dall'abside e, poiché il suolo mancava, si ebbe
l'audace idea di lanciare le navate occidentali sopra un basamento voltato, il "grande portico", raddoppiando così l'altezza della facciata.
 All'inizio del XIX secolo, la cattedrale minacciava rovina e fu, dal 1844 al 1870, oggetto non solo di un restauro, ma di una ricostruzione che risparmiò a malapena
le due navate centrali; questa ricostruzione, diretta da Mallay e poi da Mimey, preceduta da una rimozione metodica con numerazione dei materiali, offre serie garanzie di
fedeltà, eccetto per quanto riguarda il presbiterio e la cupola centrale che furono modificati senza valide ragioni. Infine, dal 1885 al 1890, il grande campanile fu completamente ma esattamente
ricostruito.
All'inizio del XIX secolo, la cattedrale minacciava rovina e fu, dal 1844 al 1870, oggetto non solo di un restauro, ma di una ricostruzione che risparmiò a malapena
le due navate centrali; questa ricostruzione, diretta da Mallay e poi da Mimey, preceduta da una rimozione metodica con numerazione dei materiali, offre serie garanzie di
fedeltà, eccetto per quanto riguarda il presbiterio e la cupola centrale che furono modificati senza valide ragioni. Infine, dal 1885 al 1890, il grande campanile fu completamente ma esattamente
ricostruito.
Il pellegrinaggio. I più antichi cronisti vellavi ci informano che, alla fine del III secolo, una vedova, sofferente di febbri maligne, intravide improvvisamente la Vergine che le ordinò di farsi trasportare sulla collina di Anis. Obbedì senza ritardo, si sdraiò su una lastra megalitica, probabilmente usata come dolmen, e si rialzò guarita. San Giorgio, allora vescovo del Velay, avvisato del miracolo, andò a visitare il roccia. Trovò, sebbene fosse luglio, uno spesso strato di neve su cui un cervo disegnò, correndo davanti a lui, l'area di una vasta chiesa. Il prelato, non potendo costruirla, ordinò di circondare il tracciato con una siepe di spine secche. Il giorno dopo, le spine avevano ceduto il posto a un roseto fiorito...
Duecento anni dopo, una paralitica del villaggio di Geyssac si stese a sua volta sulla pietra miracolosa (la Pietra delle Febbri). Si rialzò, valida, ringraziando la Vergine che, apparendo nuovamente, richiese l'erezione di una basilica sulla roccia privilegiata. (E. e P. Paul). Il vescovo San Vosy partì quindi per Roma per chiedere al papa l'autorizzazione a trasferire la sua sede da Ruessio a Anis. Tornò con un certo Scutaire, senatore e architetto, il cui nome si trova su un architrave del portico del For. È quindi lui che, negli ultimi anni del V secolo, avrebbe costruito il santuario primitivo. Così, la cattedrale del monte Anis divenne il sede di un pellegrinaggio che non si distingueva da molti altri; ma, il Venerdì Santo 25 marzo 992, attirò una tale affluenza che il papa decise la creazione di un giubileo ogni volta che il Venerdì Santo cadesse lo stesso giorno dell'Annunciazione. E insensibilmente, il pellegrinaggio perì a favore del giubileo.
 Se l'origine del culto di Notre-Dame, a Puy-en-Velay, si trova nella Pietra delle Febbri, nel Medioevo e nei tempi moderni si venerava soprattutto la famosa Vergine Nera; questa devozione era già molto in voga nel XIII secolo, e si può pensare che la celebre statua in legno di cedro fosse stata portata dall'Oriente, nel secolo precedente, da un crociato. Molti furono i re di Francia che vennero a pregare davanti a lei, riempiendo di doni il capitolo della cattedrale, e si sa che Giovanna d'Arco inviò sua madre a partecipare al giubileo del 1429 mentre lei stessa partiva per incontrare il re a Chinon.
Se l'origine del culto di Notre-Dame, a Puy-en-Velay, si trova nella Pietra delle Febbri, nel Medioevo e nei tempi moderni si venerava soprattutto la famosa Vergine Nera; questa devozione era già molto in voga nel XIII secolo, e si può pensare che la celebre statua in legno di cedro fosse stata portata dall'Oriente, nel secolo precedente, da un crociato. Molti furono i re di Francia che vennero a pregare davanti a lei, riempiendo di doni il capitolo della cattedrale, e si sa che Giovanna d'Arco inviò sua madre a partecipare al giubileo del 1429 mentre lei stessa partiva per incontrare il re a Chinon.
 Nel 1239, San Luigi offrì al capitolo di Notre-Dame-du-Puy una spina della santa corona; questa reliquia, conservata nella cattedrale fino al 1789, si trova dal 1800 nella Grande Chiesa di
Saint-Etienne.
Nel 1239, San Luigi offrì al capitolo di Notre-Dame-du-Puy una spina della santa corona; questa reliquia, conservata nella cattedrale fino al 1789, si trova dal 1800 nella Grande Chiesa di
Saint-Etienne.
Il 15 agosto si svolge attraverso la città la tradizionale processione della Vergine Nera, seguita da una folla immensa di pellegrini.
La facciata della
cattedrale comprende cinque piani di architettura in muratura policroma con decorazione di pietra mosaico, di origine auvergnate.
La scala (102 gradini) continua sotto il portico e regna, nelle prime due navate, su tutta la larghezza delle tre navate, poi, nelle due navate successive, solo sotto la grande navata centrale,
i collaterali sono quindi chiusi da porte del XII secolo le cui tavole scolpite a rilievo e incorniciate da iscrizioni rappresentano scene della Vita e della Passione di Cristo.
Su due gradini dell'androne centrale è inciso un distico: "Ni caveas crimen, caveas contingere limen, Nam regina poli vult sine sorde coli. Se non temi il peccato, temi di toccare questa soglia, perché la Regina del cielo (letteralmente del polo) vuole servitori senza macchia"; resti di pitture del XIII secolo. Si arriva così alla Porta Dorata i cui battenti, rifatti verso il 1780, conservano frammenti di ferrature romaniche. La scala un tempo saliva dritta fino al livello della navata per terminare davanti all'altare maggiore; oggi, si biforca alla quarta navata: sul pianerottolo, ai piedi di un altare, c'è l'antica Pietra delle Febbri, considerata la tavola di un dolmen, con questi versi: "Plebs hac rupe sita fit sana sopore sopita. Se chiedi perché: virtus adscribitur arae. Il popolo, ponendosi su questa pietra, si addormenta di un sonno salutare; se chiedi perché: sappi che è per una virtù attribuita a questo altare". Il ramo sinistro conduce al chiostro; si prende quello di destra che porta, tramite una nuova scala, alla navata.
 La chiesa comprende un'abside rettangolare affiancata da due absidioli, terminate da un muro dritto, un transetto sporgente di cui ciascun braccio termina con due absidioli gemelli
ed è dotato di un tribuna (la crociera è coperta da una cupola e da una lanterna fantasiosa); infine, una navata di sei campate con lati.
La chiesa comprende un'abside rettangolare affiancata da due absidioli, terminate da un muro dritto, un transetto sporgente di cui ciascun braccio termina con due absidioli gemelli
ed è dotato di un tribuna (la crociera è coperta da una cupola e da una lanterna fantasiosa); infine, una navata di sei campate con lati.
 La navata è coperta da sei cupole ottagonali su trombe, ma se si esamina ogni campata partendo dal transetto verso la facciata, si trovano nella struttura dei pilastri e delle cupole dei cambiamenti e dei raffinamenti che
dimostrano che la navata è stata costruita in questo senso in tre campagne di due campate ciascuna. Inoltre, nelle due navate occidentali, i collaterali hanno volte a ogive, mentre le altre
campate hanno volte a crociera.
La navata è coperta da sei cupole ottagonali su trombe, ma se si esamina ogni campata partendo dal transetto verso la facciata, si trovano nella struttura dei pilastri e delle cupole dei cambiamenti e dei raffinamenti che
dimostrano che la navata è stata costruita in questo senso in tre campagne di due campate ciascuna. Inoltre, nelle due navate occidentali, i collaterali hanno volte a ogive, mentre le altre
campate hanno volte a crociera.
La scala di accesso sbocca nel collaterale sud dove si vede un grande dipinto, di Giraud, che rappresenta il Giubileo del 1864. Via Crucis del 1896, in smalto, che imita gli smalti limousins del XVI secolo. Sul retro della facciata, grande e bello rilievo in legno dorato del XVIII secolo che rappresenta San Andrea sulla sua croce.
Nella navata, bella cattedra della fine del XVII secolo. L'altare maggiore, in marmo, con bei ornamenti in bronzo, del XVIII secolo, occupa il centro della crociera del transetto. È lì che si trova la celebre madonna di Notre-Dame-du-Puy, circondata da numerose lampade votive: una statua antica ha sostituito l'antica Vergine nera, bruciata nel 1794 dai rivoluzionari. L'abside è decorata con pitture moderne che riproducono gli affreschi del grande portico e della cappella dei Morti; sul fondo, bel organo della fine del XVII secolo. Di fronte all'altare maggiore, contro due pilastri della navata, statue di Giovanna d'Arco (1912) e di San Luigi (1922) che offrono la Santa Spina a Notre-Dame-du-Puy.
Nel braccio nord del transetto, absidioli e tribuna, si vedono i resti di una grandiosa decorazione dipinta del XIII e XIV secolo che abbracciava un tempo tutto il transetto, il coro e probabilmente una parte dei collaterali. Il portale di questo braccio si apre all'esterno sotto il portico di San Giovanni.
 Nel collaterale nord si notano due bei dipinti del XVII secolo, ex-voto delle pestilenze del 1629 e 1653: il primo, largo 7 metri, opera di Jean Solvain, è particolarmente
interessante perché rappresenta un'intera processione che si svolge nella piazza del For; il secondo, opera di Jean François, rappresenta, riuniti davanti alla Vergine, i sei consoli, accompagnati da San
Sebastiano, San Rocco, il procuratore della comune e il "re dell'uccello" che era il vincitore dell'ultimo tiro con l'archibugio e aveva il privilegio di accompagnare ovunque i consoli.
Nel collaterale nord si notano due bei dipinti del XVII secolo, ex-voto delle pestilenze del 1629 e 1653: il primo, largo 7 metri, opera di Jean Solvain, è particolarmente
interessante perché rappresenta un'intera processione che si svolge nella piazza del For; il secondo, opera di Jean François, rappresenta, riuniti davanti alla Vergine, i sei consoli, accompagnati da San
Sebastiano, San Rocco, il procuratore della comune e il "re dell'uccello" che era il vincitore dell'ultimo tiro con l'archibugio e aveva il privilegio di accompagnare ovunque i consoli.
 La cappella delle reliquie (visita a pagamento; rivolgersi al sagrestano), che si apre nella 3ª campata del collaterale nord, occupa il piano superiore dell'edificio dei
Machicoulis: è un maestoso nave a volta rovesciata su doppie arcate, ma un tempo era divisa in due piani da un pavimento: in basso c'era la biblioteca del capitolo, sopra la sala degli
Stati del Velay. Qui si vede il famoso affresco delle Arti Liberali, bel lavoro della fine del XV secolo che rappresenta la Grammatica con Prisciano, la Logica con Aristotele, la Retorica con Cicerone, la Musica
con Tubal.
La cappella delle reliquie (visita a pagamento; rivolgersi al sagrestano), che si apre nella 3ª campata del collaterale nord, occupa il piano superiore dell'edificio dei
Machicoulis: è un maestoso nave a volta rovesciata su doppie arcate, ma un tempo era divisa in due piani da un pavimento: in basso c'era la biblioteca del capitolo, sopra la sala degli
Stati del Velay. Qui si vede il famoso affresco delle Arti Liberali, bel lavoro della fine del XV secolo che rappresenta la Grammatica con Prisciano, la Logica con Aristotele, la Retorica con Cicerone, la Musica
con Tubal.
Si terminerà con la visita della sagrestia, situata in fondo al collaterale sud: a sinistra dell'entrata, la tomba di Mons. Le Breton (t 1886), con giacente in marmo.
Sagrestia (si visita con il sagrestano al di fuori degli uffici). Pietà della fine del XV secolo, magnifico primitivo francese; reliquiario del XV secolo in rame argentato; bel Cristo in avorio del XVIII secolo in una superba cornice; bei pannelli in legno scolpito del XVIII secolo, opera di Vaneau o dei suoi allievi. Tra i dipinti: Adorazione dei Magi di Claude Vignon; Strage degli Innocenti di Sébastien Bourdon. Le persone qualificate potranno ancora vedere la celebre "bibbia di Teodulfo, ammirevole manoscritto francese del IX secolo su velluto porpora.
Dietro l'abside, tra la sagrestia e il campanile, la piccola corte della prevostura racchiude un pozzo medievale, a cui si riferisce un'iscrizione latina incisa sul muro dell'abside: "Per grazia divina, questa fontana è per gli ammalati un rimedio che supplisce gratuitamente alle carenze dell'arte di Ippocrate". Sotto questa iscrizione, frammenti di bassorilievi gallo-romani, provenienti da un grande edificio, sono stati incastonati nelle basi inferiori dell'abside: rappresentano Ercole, scene di caccia e combattimenti di animali.
 Nella cappella situata sotto il campanile si trovano tre tombe del XIV secolo (un vescovo e due canonici). Si può uscire direttamente da questa cappella davanti al portico di San Giovanni.
Nella cappella situata sotto il campanile si trovano tre tombe del XIV secolo (un vescovo e due canonici). Si può uscire direttamente da questa cappella davanti al portico di San Giovanni.
 Si esce dalla cattedrale attraverso il braccio sud (a destra) e il portico del For, ammirabile pezzo di architettura della fine del XII secolo, situato nell'angolo di questo
braccio: è coperto da una volta a ogive mentre, per tutti gli altri elementi, è ancora romanico. Si nota la disposizione eccezionale dell'arco staccato, riunito all'archivolto da
tre cunei di pietra, uno dei quali rappresenta un piccolo personaggio.
Si esce dalla cattedrale attraverso il braccio sud (a destra) e il portico del For, ammirabile pezzo di architettura della fine del XII secolo, situato nell'angolo di questo
braccio: è coperto da una volta a ogive mentre, per tutti gli altri elementi, è ancora romanico. Si nota la disposizione eccezionale dell'arco staccato, riunito all'archivolto da
tre cunei di pietra, uno dei quali rappresenta un piccolo personaggio.
Sotto il portico si aprono due porte: la più piccola o porta papale, riservata ai papi, ha un architrave antico trovato durante scavi effettuati nella cattedrale e riportato qui nel 1847: porta l'iscrizione Scutari papa vive Deo che conserva il ricordo dell'architetto del V secolo; il retro porta un'iscrizione pagana più antica. L'altra porta è puramente romanica: i battenti sono ornati con due teste di leoni in bronzo, degli originali custoditi nel museo Crozatier.
Sopra il portico c'è una cappella costruita verso il 1300 di cui, all'incontro con il portico, le aperture sono gotiche mentre è voltata a crociera: nonostante la differenza di stile, completa armoniosamente il portico.
Il portico si affaccia sulla piazza del For (dei Messaggi), in terrazza a sud del lato della città (bella vista), e il lato ovest è bordato dall'Episcopio, adiacente alla cattedrale: è un affascinante edificio, con chiostro centrale, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo Antoine de Saint-Nectaire. Di fronte, l'hotel di Saint-Vidal, dei XV e XVI secolo, vicino al quale si apre una pittoresca viuzza a gradini, anticamente conosciuta con il nome di scala Boiteux o Crebacor (crepa-cuore; oggi, salita del Chiostro), che scende direttamente nella via del Cardinale-de-Polignac.
 Dalla piazza del For,
contornando la sagrestia e il campanile della cattedrale lasciando a destra la strada e la porta San Giorgio, si arriva in pochi passi davanti alla grande arcata ribassata del portico di San Giovanni, situato
nell'angolo del braccio nord che unisce al battistero. Sotto il portico, il timpano del portale romanico rappresenta Cristo tra due angeli mentre l'architrave rappresenta l'Ultima Cena: queste sculture
sono state rasate durante la Rivoluzione. I battenti, restaurati, hanno conservato le loro ferrature del XII secolo. Sopra il portico, una sala voltata a crociera contiene un bel camino con cappa conica. A destra si trova il battistero di San Giovanni (un custode fa visitare; remunerazione).
Dalla piazza del For,
contornando la sagrestia e il campanile della cattedrale lasciando a destra la strada e la porta San Giorgio, si arriva in pochi passi davanti alla grande arcata ribassata del portico di San Giovanni, situato
nell'angolo del braccio nord che unisce al battistero. Sotto il portico, il timpano del portale romanico rappresenta Cristo tra due angeli mentre l'architrave rappresenta l'Ultima Cena: queste sculture
sono state rasate durante la Rivoluzione. I battenti, restaurati, hanno conservato le loro ferrature del XII secolo. Sopra il portico, una sala voltata a crociera contiene un bel camino con cappa conica. A destra si trova il battistero di San Giovanni (un custode fa visitare; remunerazione).
 È un curioso edificio dell'XI secolo con un'abside ornata da cinque nicchie incorniciate da colonne gallo-romane di bassa epoca; la parte inferiore delle mura è fatta di
grandi blocchi provenienti anche da un edificio antico. La navata comprende due campate: la prima, coperta da una volta a crociera che sostiene una tribuna, conserva resti di affreschi; la seconda, la cui
volta, oggi scomparsa, sembra essere stata una sorta di cupola esagonale. I fonti battesimali occupano una nicchia a sinistra. Al centro della navata, si vede l'impronta di una piscina che è forse
il resto di un battistero risalente all'epoca in cui il battesimo si dava per immersione.
È un curioso edificio dell'XI secolo con un'abside ornata da cinque nicchie incorniciate da colonne gallo-romane di bassa epoca; la parte inferiore delle mura è fatta di
grandi blocchi provenienti anche da un edificio antico. La navata comprende due campate: la prima, coperta da una volta a crociera che sostiene una tribuna, conserva resti di affreschi; la seconda, la cui
volta, oggi scomparsa, sembra essere stata una sorta di cupola esagonale. I fonti battesimali occupano una nicchia a sinistra. Al centro della navata, si vede l'impronta di una piscina che è forse
il resto di un battistero risalente all'epoca in cui il battesimo si dava per immersione.
Passando a destra sotto il portico di San Giovanni, si trova a sinistra l'entrata del chiostro, la cui visita è indispensabile.
Il chiostro, di forma rettangolare, è un'opera notevole del XII secolo, fortemente restaurato dal 1850 al 1857, di un'ordinanza semplice e maestosa, le cui quattro gallerie sono voltate a crociera; la galleria adiacente alla cattedrale, più antica, può risalire all'inizio del secolo. I più bei capitelli sono imitati dallo stile corinzio; alcuni capitelli istorici sono di fattura meno abile; ma si nota soprattutto, sopra i peducci mosaicati, una splendida cornice dove la verve fantasiosa del Medioevo si è espressa liberamente con un meraviglioso senso della decorazione.
La sua galleria ovest comunica con il portico della cattedrale tramite un passaggio chiuso da una ammirabile griglia romanica.
La galleria est del chiostro è bordata da una vasta
sala voltata a crociera, che, inizialmente sala capitolare, servì, a partire dal XIV secolo, come cappella funeraria e cimitero per i canonici; è, per questo motivo, conosciuta come cappella dei
Morti: vi si entra attraverso una griglia del XV secolo; si vede un grande e bel affresco del XIII secolo che rappresenta la Crocifissione, e molte pietre tombali addossate ai muri. Il piano superiore conserva
un bel camino romanico e si vedono resti di pitture nelle soffitte.
 La galleria ovest è dominata dal edificio dei Machicoulis, potente costruzione del XII secolo adiacente alla cattedrale e il cui piano superiore è occupato dalla
cappella delle Reliquie. Sotto ci sono due piani di magazzini e cantine (vasche in pietra e torchi del Medioevo). Questo edificio era affiancato, alla sua estremità nord, da un grosso donjon
quadrato, la torre San Mayol, abbattuta nel 1844, che completava l'insieme fortificato formato dalla cattedrale e dall'episcopio.
La galleria ovest è dominata dal edificio dei Machicoulis, potente costruzione del XII secolo adiacente alla cattedrale e il cui piano superiore è occupato dalla
cappella delle Reliquie. Sotto ci sono due piani di magazzini e cantine (vasche in pietra e torchi del Medioevo). Questo edificio era affiancato, alla sua estremità nord, da un grosso donjon
quadrato, la torre San Mayol, abbattuta nel 1844, che completava l'insieme fortificato formato dalla cattedrale e dall'episcopio.
 In un altro edificio del chiostro, a nord, si visita il museo Notre-Dame.
In un altro edificio del chiostro, a nord, si visita il museo Notre-Dame.
1ª sala. Numerosi ex-voto dipinti lasciati un tempo alla cattedrale da pellegrini riconoscenti; si notano quelli di Jacques d'Apchier (1513), di Saint-Nectaire (1584), di Renée de Rambures,
marchesa di Polignac (1690), della città di Langogne (1723). I consoli dell'anno 1598, del pittore Josué Parier, del Puy. Modellini per la statua di
Notre-Dame de France. A. Besqueut, Il sacerdozio, marmo.
2ª sala. In fondo alla sala, grande arazzo fiorito della fine del XV secolo, donato da Jean de Bourbon, vescovo del Puy-en-Velay. Diverse statue in legno, di Vaneau (XVII secolo), tra cui due soldati
della legione tebana scolpiti per la tomba di Mons. de Béthune. Un pannello dello stesso Vaneau rappresenta Mons. de Béthune. Nelle vetrine: incensiere in bronzo del XII secolo; cassa in smalto limousin del
XIII secolo; ciborio gotico in argento; anello pastorale del XIV secolo; morso di capa romanica; ricami d'argento provenienti da mantelli dell'ordine dello Spirito Santo; due bei mantelli ricamati, uno del XIV,
l'altro del XV secolo, che un tempo servirono a ornare la statua della Vergine Nera bruciata nel 1794; pontificale di Mende, manoscritto del XIV secolo; genealogia di Cristo, lungo
pergamena del XV secolo.
Girando a sinistra all'uscita del chiostro, si raggiunge in pochi passi la cappella dei Penitenti, la cui porta è datata 1584 e conserva i battenti rinascimentali, ma che è stata completamente restaurata nel XVIII secolo (suonare il custode; remunerazione).
 Il soffitto a cassettoni
è interamente decorato con pitture eseguite nel 1630 da François Guy (al centro, l'Assunzione). I grandi quadri che ornano la tribuna e i lati della cappella, dovuti ad artisti locali, risalgono solo al 1713. Ma bisogna soprattutto vedere, nella grande tribuna, una folla di oggetti antichi utilizzati dai Penitenti: è un vero e proprio piccolo museo dedicato a queste confraternite, quasi tutte
scomparse attualmente. Tuttavia, quella dei Penitenti Bianchi del Puy-en-Velay esiste ancora, e si possono vederli, vestiti con il loro curioso costume, nella grande processione del 15 agosto.
Il soffitto a cassettoni
è interamente decorato con pitture eseguite nel 1630 da François Guy (al centro, l'Assunzione). I grandi quadri che ornano la tribuna e i lati della cappella, dovuti ad artisti locali, risalgono solo al 1713. Ma bisogna soprattutto vedere, nella grande tribuna, una folla di oggetti antichi utilizzati dai Penitenti: è un vero e proprio piccolo museo dedicato a queste confraternite, quasi tutte
scomparse attualmente. Tuttavia, quella dei Penitenti Bianchi del Puy-en-Velay esiste ancora, e si possono vederli, vestiti con il loro curioso costume, nella grande processione del 15 agosto.
All'angolo della cappella si apre una pittoresca viuzza, tagliata da due passaggi voltati, che scende direttamente ai portali romanici dell'Hôtel-Dieu e all'Hospice generale.
 Oltre la cappella dei Penitenti, si apre il sentiero del roccia Corneille (ingresso 5 fr., dalle 8:00 alle 19:00) la cui ascesa è piuttosto faticosa, ma da cui si gode
di un panorama incomparabile.
Oltre la cappella dei Penitenti, si apre il sentiero del roccia Corneille (ingresso 5 fr., dalle 8:00 alle 19:00) la cui ascesa è piuttosto faticosa, ma da cui si gode
di un panorama incomparabile.
La salita è segnata da una via crucis di semplici croci di legno, portate il 14 agosto 1942 dai pellegrini in cammino, durante un grande pellegrinaggio della gioventù francese, erette il 27 maggio 1944 da Mons. Martin. Scale conducono alla piattaforma della roccia (755 m di alt.; 130 m sopra la piazza del Breuil), dove si erge la colossale Vergine.
La statua di Notre-Dame di Francia (1860) è stata fusa, secondo il modello di Bonnassieux, con 213 cannoni presi a Sebastopoli. Alta 16 m., larga circa 4 m., pesa 110 tonnellate e poggia su un piedistallo ottagonale di 6 m. 70. Il monumento è composto da 80 pezzi riuniti da bulloni. Si può salire all'interno tramite una scala di 91 gradini, fino alla scala in ferro che consente di raggiungere la corona (ascesa faticosa e poco interessante).
Sulla piattaforma della roccia, ai piedi della Vergine, statua inginocchiata di Mons. de Morlhon (t 1862), bronzo di Bonnassieux. Una tavola di orientamento in lava di Volvic permette di delineare l'ammirevole panorama che si estende sulla città e sul circo verdeggiante di cui occupa il centro; sullo straordinario roccia di Aiguilhe e il donjon di Polignac, a nord-ovest; i monti del Velay, a ovest; la catena del Megal, a est, e il massiccio del Mézenc, a sud-est.
Si domina, a nord, un elegante ponte gotico, stretto e curvo, che attraversa la Borne. A ovest, si vedono, quasi spalla a spalla, il ponte moderno della strada di Brioude e il ponte medievale; oltre, il borgo e la roccia di Espaly, sovrastata da una colossale statua di San Giuseppe. Si ridiscende per lo stesso sentiero e, passando sotto il portico di San Giovanni, si segue a sinistra la via di San Giorgio che è attraversata dalla porta di San Giorgio, resta dell' recinto fortificato della cattedrale. Di fronte, la cappella del seminario, davanti alla quale si gira a destra per attraversare un'altra porta e sbucare su un incrocio, davanti a un'altra cappella. Dall' incrocio, si segue a destra la via del Cardinale de Polignac: al n° 26, bel portale del XVII secolo; tra i n° 24 e 22, due vecchie torri; n° 16, hotel gotico-rinascimentale; n° 8, antico hotel di Polignac, flamboyant, che servì un tempo da prefettura.